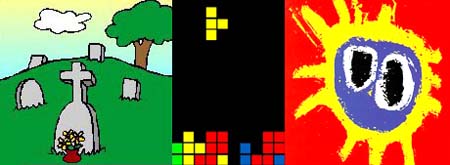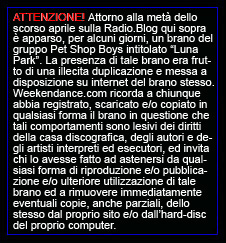|
Yesterday's Papers
(Re)Light My Fire: ce ne frega ancora qualcosa dei Doors? (Hot)
Trentemøller, il Vasco Rossi della techno (Hot)
I ♥ Pet Shop Boys (nonostante tutto...) (Hot)
The Hours: Damien Hirst ha fondato una band (o forse no) (Hot)
SXSW: la volta all'anno che Austin diventa la capitale dell'indie mondiale
(Repubblica XL)
Bob Marley: la leggenda del santo fumatore (Io Donna)
Mile High Punk: ragionare sui Sex Pistols a 10.000 metri d'altezza (Hot)
Lacuna Coil: la cui cantante, nel caso non si fosse capito, è gnocca (Repubblica XL)
Jim Kerr: che voleva dire, esattamente, "nuovo sogno dorato"? (Io Donna)
Coldcut: "È imprevedible quello che succede quando il suono incontra la vita" (Hot)
45giri: il formato che doveva morire (Hot)
Hard-Fi: quelli che Scarlett Johansson non ha mai sentito nominare (Repubblica XL)
Incontrare Ursula Rucker e chiederle: "ma tu scrivi prima la musica o i testi?" (Hot)
Arctic Monkeys: come internet trasformò un cartone animato in realtà (Repubblica XL)
Tiga: "la prima volta che ti chiedono un remix è come la prima volta che baci una ragazza" (Hot)
Da Brian Eno ai Franz Ferdinand: di che cosa parliamo quando parliamo di "art-rock"? (Hot)
The Strokes: "il CBGB's? che si fotta" (Repubblica XL)
Confessions On a Dancefloor: Madonna e l'ultimo capodanno dell'umanità (Hot)
Mister Cartoon: il tatuatore più famoso del mondo e il suo ferro da stiro (Hot)
Art Brut: "abbiamo formato una band" (Hot)
Ozzy Osbourne: un vecchio zio nella casa degli orrori (Repubblica XL)
Tracey, Damien e Grayson: sai tenere un Segreto? (Io Donna)
Scuola Furano: fuga dalla scuola media (Hot)
Roisin Murphy: quella sua maglietta stretta (Rolling Stone)
Violante Placido, per gli amici Viola (Io Donna)
Joy Division, the movie: non esattamente Last Days, e nemmeno The Doors (Hot)
30 domande a... WhoMadeWho (Hot)
Allun, Offlaga, Uochi Toki e gli altri: marziani italiani (Repubblica XL)
Devendra, Sufjan, Rufus: le radici in un passato immaginario (Hot)
Sigur Ros: niente più strategia dell'oscurità , o quasi (Repubblica XL)
Arcade Fire: sette musicisti, tre funerali e un matrimonio (Repubblica XL)
C30-C60-C90: il culto del mixtape (Hot)
"Piripiri-piripiri-piripiri-pi": più famosa di Yesterday dei Beatles (Io Donna)
Tosca + The Dining Rooms: due dischi, quattro musicisti e sette bambini (Hot)
E arrivò il giorno in cui i lettori del Corriere conobbero le Coco Rosie... (Io Donna)
Tattoo You: sì, nel 2005 c'è ancora qualcuno che scrive articoli sui tatuaggi (Hot)
Springsteeniani d'Italia: il culto di Bruce (Io Donna)
From Genesis to revelation: la dj-culture scopre il prog? (Hot)
It began in Ibiza: la Summer of Love e tutto il resto (Hot)
A Grottaferrata, a sentire il nuovo album dei Subsonica, mentre loro mi guardano strano (Rolling Stone)
Joss Stone: mind the Gap, please (Io Donna)
Red Bull Music Academy: la scuola per dj più pazza del mondo (Rolling Stone)
Sk8r boi 2005: la musica che gira intorno allo skate (Hot)
Antony & The Johnsons: "volevo essere Isabella Rossellini" (Rolling Stone)
Coldplay/Guns'N'Roses: scusate il ritardo (Io Donna)
World Wide Clubbing: prima viaggiare, poi ballare (Hot)
Moby: "voglio vivere come dentro una tomba"
(Io Donna)
Discoinferno: i dieci anni che cambiarono il clubbing a NY (Rolling Stone)
Belle de Jour: "anal sex is the new black" (Io Donna)
Optimo: i biscotti per cani e il futuro del djing (Hot)
Polyphonic Spree: il meraviglioso mondo di Tim DeLaughter
(Musica di Repubblica)
Mercury Rev: in segreta migrazione (Rumore)
EMA: (mica tanto) European Music Awards (Io Donna)
White Stripes: i Kraftwerk del 2000? (Rolling Stone)
Kasabian: il Gabibbo e Charles Manson
(Musica di Repubblica)
The Cure: la vita è un lungo fascinoso imbrunire
(Rolling Stone)
Miss Violetta Beauregarde: ultra-Violetta! (Rumore)
Franz Ferdinand: il successo è una cosa che succede
(Musica di Repubblica)
Lollapalooza: Woodstock per la Generazione X
(Rolling Stone)
Io tigro, tu tigri, loro Le Tigre... (Rumore)
Duran Duran: Wild Boys vent'anni dopo
(Musica di Repubblica)
Radio Dept.: Radio Free Sweden (Rumore)
Milano-Roma-Barcellona: trans Soulwax express (Rumore)
The Libertines: "vuoi sapere che si prova ad avere nella band un potenziale Sid Vicious?"
(Musica di Repubblica)
Gabrielle Drake: Pink (Moon)base
(Rolling Stone)
Janet Jackson: e Dio creò le tette (GQ)
Discocaine: viaggio al termine del nightclubbing (Hot)
Beastie Boys: To The 5 Boroughs (Rumore)
2004: dance is (not) dead? (Rumore)
The Streets: "pensavo di essere noiosissimo, pensavo che nessuno mi capisse"
(Tutto/Rumore)
Golia & Melchiorre: un Bugo, anzi due (Rumore)
Malcolm McLaren: comprereste un'auto usata da quest'uomo? (Hot)
Do you remember the Summer of Love? (Rolling Stone)
PJ Harvey: e alla fine arriva Polly (Jean) (Rumore)
William Gibson: non tutte le predizioni devono per forza avverarsi (Tutto)
The Darkness: old Skool of Rock (Rumore)
Morrissey: un alieno a L.A. (Rolling Stone)
Von Bondies: Detroit, botte & rock'n'roll (Rumore)
Courtney Love: la fidanzata d'America (Rumore)
Coldplay: livin' la vida glamour (Rumore)
Iggy, ti presento Peaches... (Rumore)
Black Rebel Motorcycle Club: belli, neri e ribelli (Rumore)
The Rapture: punk, funk, moda & modelle (Rumore)
The Queer is Dead: trent'anni di rock non-solo-eterosessuale (Rumore)
I Maniaci Dei Dischi: il futuro è un dj a sei mani (Rumore)
La strada di Zwan: Billy Corgan e il tempo ritrovato (Rumore)
"Così Tanto Amore da Dare": in giro per Londra a caccia di Dj Falcon (Rumore)
Massive Attack: 3D, cuore di tenebra (Rumore)
Sigur Ros: "il mondo è più divertente di quel che potresti credere" (Rumore)
The Osbournes: gruppo di famiglia in un inferno (Rumore)
Last Night a DJ Saved My Life: essere dj nel 2002 (Rumore)
Primal Scream: "il problema è che noi non siamo gli Oasis" (Rumore)
David Holmes: una vita per il cinema (Rumore)
My Bloody Valentine: soffice come la neve (ma caldo dentro) (Rumore)
Stuart David: fold your book, child... (Rumore)
Chemical Brothers: è iniziato in Africa-ka-ka-ka... (Rumore)
Money Mark: lo spirito delle persone si infonde nelle macchine (Rumore)
Non solo Anniottanta: il lato oscuro dell'Eighties-revival (Rumore)
Solex: ovvero Beck con le mestruazioni (Rumore)
Starsailor: "purezza" è la parola chiave (Rumore)
Lamb: l'opposto dell'amore non è l'odio, ma la paura (Rumore)
Verdena: paura & disgusto dalle parti di Bergamo (Rumore)
Quando incontri Bjork e poi parenti e amici ti chiedono: "ma com'è lei veramente?" (Rumore)
Copia Icona: Thora Birch e il congelamento di Kate Moss (Rumore)
The rhythm, the traxx, the Basement, the Jaxx... (Rumore)
Radiohead: "odiare la musica è pericoloso" (Rumore)
Damon & Jamie: Gorillaz nella nebbiaz (Rumore)
Tool: i Radiohead del post-metal (Rumore)
Depeche Mode: l'heavy metal dello spazio interiore (Rumore)
Soft Cell: quest'ultima notte a Sodoma (Rumore)
Die Moulinettes: brevi amori a Jesolo e Bibione (Rumore)
Future Pilot AKA: Wild Thing dei Troggs è l'equivalente pop dell'uomo delle caverne (Rumore)
Daft Punk: 0ne m0re t1me? (Rumore)
Kings Of Convenience: un mondo di canzoni ideali (Rumore)
Riot Grrrls 2001: girls just want to have fun? (Rumore)
La Crus & Avion Travel: i nuovi tradizionalisti (Rumore)
Me and Alan McGee: le etichette che hanno fatto la storia, da Rough Trade alla Creation (Rumore)
Giuliano Palma & The Bluebeaters: it's a wonderful, wonderful life (Rumore)
Il giorno che Roni Size mi mandò (quasi) a quel paese (Rumore)
Mtv (de)Generation: vogliono trasformarci in Arancia Meccanica, ma noi siamo più veloci (Rumore)
Belle & Sebastian: "talvolta al mattino mi sveglio e mi sento Andy Warhol" (Rumore)
Yoshinori Sunahara: il non-luogo dell'anima (Rumore)
Londra: 333 italiani("D" di Repubblica)
Mr.Oizo: l'uomo che muove il pupazzo (Rumore)
Nine Inch Nails (e Marylin Manson): speranza e vaselina (Rumore)
Stupiti & Confusi: apologia (o quasi) di Chloe Sevigny (Rumore)
Mò Wax: non necessariamente trip-hop(Dance Music Magazine)
Pop Life!: dai Beatles ai Boo Radleys passando per i Sex Pistols (Rockstar)
"Generazione M": i ragazzi con la spina nel fianco (Rumore)
Tuesday, August 15, 2006
Higher than the sun
a
a
Ho guidato per tutta la notte. Che detto così sarebbe una perfetta canzone di Bruce Springsteen. Ma la realtà è un po’ meno romantica: in verità ho guidato solo quattro ore, dalle quattro e un quarto alle otto e venti di una domenica mattina, circondato dai miei due anziani genitori semiaddormentati e da tutti i loro bagagli. Quattrocentoventi chilometri di strade scure e sature di umidità come una vecchia cantina, che mano a mano diventavano sempre meno scure e meno umide, fino al trionfo di azzurro cobalto e verde rabbioso - e un’incredibile sfumatura di marrone, al tempo stesso profonda ed elettrica, da vecchia cartolina ritoccata - degli ultimi cento chilometri di autostrada del Brennero, tra Verona e Trento. Fino a un certo punto, fino a che era ancora buio, l’unica compagnia sono stati i bli-blip degli sms com i quali FR Homes mi relazionava della sua notte brava in giro per disco toscane con una cricca di amici gay a ballare i Chemical Brothers. Hey boy, hey girl? La sensazione, Chemical Brothers a parte, è che poteva essere una notte d’agosto del 1984, e potevano essere cartoline imbucate agli autogrill anziché sms. Tanto più che io li ho letti tutti insieme, in una stazione di servizio più o meno all’altezza di Brescia Ovest, esattamente come fossero cartoline ritrovate alla fine dell’estate nella cassetta delle lettere (i primi cinque minuti impiegati a cercare di ricostruire l’esatta sequenza cronologica).
Niente: è successo che tra i doveri di bravofiglio da quest’anno è entrato in top ten anche l’accompagnare gli anziani genitori in montagna con la loro macchina, perché il caldo, il traffico, le strade di ferragosto che richiedono il loro tributo di sangue e tutti gli altri perché che non vi sto a dire. Per farla breve, mi sono ritrovato alle otto di una domenica mattina in un posto che è il posto nel quale ho trascorso tutte le estati dai cinque ai diciassette anni, e nel quale non mettevo piede da, uhm, più di vent’anni, con sei ore di tempo da riempire prima del primo treno utile per scappare via e tornare nel 2006. Sospetto che il mio cervello abbia immediatamente iniziato a processare tutto quello che stava vedendo come fosse parte di una specie di episodio pilota di una nuova serie di Twilight Zone, ma non pensate a nulla di minaccioso o deplorevole. In realtà, mentre mi incamminavo lungo la strada che portava al centro del paese, costeggiando polverosi campi di grano e cespugli di ortica e di quei fiori che schiacciandoli fra due dita fanno “pop”, l’unica cosa un po’ minacciosa che sentivo (e ci ho messo un po’ a capire cos’era) era una totalmente irrazionale paura di incontrare me stesso, in bicicletta, all’età di nove anni.
Cioè: che cosa avrebbe pensato del me stesso di ora il me stesso di nove anni? Avrebbe riconosciuto, sotto gli occhiali, sotto la pelle stanca, sotto il sorriso appesantito, qualcosa di familiare? Avrebbe pensato ad un cugino arrivato dall’estero di cui nessuno gli aveva mai parlato? Oppure avrebbe capito subito chi aveva di fronte - in fondo anche se Ritorno al futuro non era ancora uscito, i paradossi cronologici alla Tales Of The Unexpected li conoscevo bene dai fumetti Marvel - e avrebbe detto: «cosa ne hai fatto di me, dei miei sogni, delle mie speranze?».
Oppure non avreebbe detto nulla, aspettando che fosse il me stesso di trent’anni dopo a parlare. (E io, cosa mi sarei detto? Cosa avrei potuto dirmi? «Ehi, compra quanti più modellini di robot giapponesi ti riesce, ma non aprirli, tienili chiusi dentro alle scatole originali, così quando tu sarai me li rivendiamo su eBay. No, è troppo complicato spiegarti cos’è eBay. Tu fidati, e diventeremo ricchi»). Oppure ancora avrebbe tirato dritto senza quasi accorgersi di me, registrando appena la notizia della mia esistenza ai margini del suo campo visivo, che sarebbe in fondo la cosa più giusta.
A parte questo, camminare vent’anni dopo dentro il set del proprio passato è una sensazione strana che richiede soprattutto un continuo lavoro di rimessa a fuoco: che ci fa quella villetta bifamiliare con il portico palladiano alla Thomas Jefferson in mezzo al prato? quando avranno aggiunto quel cancello a quel vialetto? e quando avranno asfaltato quella strada? E le parabole sui tetti. L’ultima volta che ho camminato in questo posto non esisteva Sky, non esisteva Google, non esisteva niente di niente. La cosa più moderna che esisteva a quei tempi era una sala giochi con Phoenix e quell’altro pazzesco arcade di pura grafica vettoriale verde e nera dove tu pilotavi un carro armato nel deserto. Anche la televisione esisteva già. Ricordo che l’ultima estate che ho passato qui, il sabato notte con i cugini ci si riuniva a vedere DeeJay Television sull’unico televisore che riusciva, attraverso un pesante velo di effetto neve, a captare Italia Uno.
In realtà non è vero, non è vero nulla. Non è vero che camminare lì era solo una strana sensazione di spaesamento cronologico. In realtà mano a mano che il sole saliva verso il centro del cielo e il caldo aumentava mi sentivo sempre più prigioniero: e non del mio passato, ma del mio presente. E quello che sentivo crescere dentro non era spaesamento, ma la certezza - alimentata dal silenzio e dall’ondeggiare lento del granoturco nei campi - che il mio cuore stesse per spezzarsi in due come un fossile. È stato a quel punto, un po’ prima di arrivare al centro del paese, che ho imboccato una strada secondaria e sono finito davanti all’ingresso del piccolo cimitero locale. Qui mancavo da un po’meno tempo: l’ultima volta che c’ero stato era circa quindici anni fa, per seppellire mia nonna. Era la settimana in cui NME recensiva Beleza Tropical - Brazil Classics Vol. 1 - compiled by David Byrne, quindi doveva essere il 1989. Era la fine dell’inverno, e durante il viaggio avevo letto un romanzo di Nathanael West.
Ho superato il cancelletto bianco: le montagne brillavano sullo sfondo come l’etichetta dell’acqua minerale che probabilmente ancora adesso imbottigliano lì vicino, uno o due chilometri da lì. Ho girato un po’ a caso, nel quadrante in cui ricordavo vagamente dovesse trovarsi la tomba. Finchè non è apparsa: una tomba di marmo rossiccio come la vasca da bagno di Robbie Williams. Che strana cosa le tombe di famiglia: per chi è ancora vivo, è come avere una casa al mare nell’aldilà. Per contrasto mi è venuto in mente Johnny Thunders, che nel suo testamento aveva espressamente chiesto di essere cremato e che le sue ceneri, divise in righe, venissero tirate su col naso dai partecipanti alla cerimonia funebre (sembra anche che qualcuno l’abbia fatto).
Insomma, ero lì che girellavo attorno alla tomba di famiglia e perdevo tempo. Ed a quel punto ho cominciato a parlare con te, come ogni tanto faccio ancora, anche se è passato così tanto tempo.
Se tu ci fossi ancora, se tu ancora esistessi, probabilmente avremmo litigato, come facevamo sempre. Tu avresti detto che un cimitero non è un posto in cui portare una bambina di pochi anni, io ti avrei detto che al contrario un piccolo cimitero di montagna è il posto ideale per avvicinarsi ad un senso di continuità con il passato, per familiarizzare con il fatto di appartenere ad un mondo in cui prima di te ci sono state altre persone, e insieme a te e dopo di te ci sarà sempre qualcuno, e tutti in qualche modo sono legati tra loro, tutti in qualche modo siamo legati tra noi, dal ricordo e da emozioni strane e spesso incomprensibili.
«Vuoi che cresca con la sensazione di essere un puntino solitario nel buio dello spazio oppure sentendosi parte di una costellazione luminosa con un nome belllissimo e misterioso come Orione o Alpha Centauri?», ti avrei detto. Tu avresti chiuso il discorso dicendo «fai un po’ come vuoi», ma sotto sotto so che avresti riso della mia impeccabile retorica. E al ritorno lei ti avrebbe abbracciata e ti avrebbe raccontato del campo di addestramento per cuccioli di cane lupo che c’è subito dietro il cimitero, e dei fiori che schiacciandoli fanno “pop”.
«Papà, perché la gente muore?»
«È come il Tetris, piccolina. Fa parte del gioco. A Tetris sai già che alla fine sarà la macchina a vincere, ma la differenza la fa quanto a lungo riesci a far durare la partita, e i punti e i bonus che accumuli.»
«Papà?»
«Sì piccolina?»
«Non ho capito.»
«Allora... uhm, lascia perdere il Tetris. Ecco: è come passare dall’asilo alle scuole elementari, o dalle elementari alle medie. Quando cresci non ti diverti più a fare le cose che facevi all’asilo, vuoi farne altre e... per questo vai in un altro posto. Per le persone, quando muoiono, è un po’ così.»
«Ah, ecco.»
Secondo me il Tetris è la più perfetta metafora della vita intelligente su questo pianeta. Non solo perché non puoi vincere ma soltanto provare a far durare la partita più a lungo possibile. Pensate ai parallelepipedi che cadono come a delle piccole unità di energie emotive: adesso pensate ad ogni parallelepipedo caduto in una posizione sbagliata come ad un piccolo infarto neuronale, un filamento di nevrosi, uno sclerotizzarsi del tessuto emotivo che intasa il libero fluire delle energie. Pensate alla fatica per uscire da una combinazione sfortunata di pezzi sputati fuori dal generatore random. Pensate a come ogni nuova mossa sbagliata porti sempre più rapidamente al collasso del sistema ed alla fine della partita. Pensate a come una somma di mosse sbagliate disegni rapidamente un panorama di ansia, paura, soffocamento e perdita di lucidità. Pensate al senso di sconfitta che accompagna la fine anche della migliore partita a Tetris: la sensazione di “però potevo fare meglio”.
«Papà?»
«Sì piccolina.»
«Quel signore nel cd che tu ascolti sempre ha mal di pancia?»
«In un certo senso ha un peso sullo stomaco, piccolina, è vero. Si chiama James Murphy, e abita a New York. Ehi, ho una foto di lui qui sul computer, vuoi vederla? Guarda che pancia grande che ha»
«W-o-w! Gli deve fare malissimo, la pancia!»
Invece niente.
Niente luna di miele, niente mensole da montare, niente coprivestito verde di carta e mascherina mentre ti tengo la mano e tu che conti fino a tre e spingi, niente consulente matrimoniale per il settimo anno. Per un attimo - lì dentro al cimitero, cercando di non incrociare gli sguardi delle anziane signore che già al mattino presto si affacendavano attorno al rubinetto dell’acqua con i loro vasi, sperando che a nessuna di loro venisse in mente di rivolgermi la parola deducendo la mia identità sulla base della tomba di fronte alla quale ero fermo - per un attimo mi è stato chiaro che nella mia vita Ho Perso Più Di Quanto Potrò Mai Avere Indietro. Come la canzone dei Primal Scream, I’m Losing More Than I’ll Ever Have.
E un istante dopo mi è venuta in mente questa cosa: cioè che I’m Losing More Than I’ll Ever Have è la canzone decostruendo la quale i Primal Scream (insieme al dj e produttore Andrew Weatherall) hanno creato Loaded, cambiando per sempre il corso della loro carriera e della musica pop in generale. Fino a un attimo prima c’era una malinconica canzone indie pop dal vago retrogusto gospel, e un attimo dopo invece c’è questa fantastica scheggia impazzita di psichedelia soul downtempo dove la voce di Peter Fonda (incrociata a quella di Bobby Gillespie) sembra parlarti di redenzione, di riscatto e di rinascita. L’elemento imponderabile che fa saltare per aria la configurazione del Tetris. A quel punto mi è stato chiaro che il senso della vita è riuscire a decostruire la propria I’m Losing More Than I’ll Ever Have per trovare la corrispondente Loaded. E non è affatto facile, no.
Non è affatto facile, sai? Sciogliere il grumo di petrolio che sembra imprigionare ogni Loaded di questo mondo prima che venga alla luce. No, non è affatto facile.
|