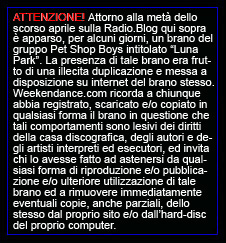|
Yesterday's Papers
(Re)Light My Fire: ce ne frega ancora qualcosa dei Doors? (Hot)
Trentemøller, il Vasco Rossi della techno (Hot)
I ♥ Pet Shop Boys (nonostante tutto...) (Hot)
The Hours: Damien Hirst ha fondato una band (o forse no) (Hot)
SXSW: la volta all'anno che Austin diventa la capitale dell'indie mondiale
(Repubblica XL)
Bob Marley: la leggenda del santo fumatore (Io Donna)
Mile High Punk: ragionare sui Sex Pistols a 10.000 metri d'altezza (Hot)
Lacuna Coil: la cui cantante, nel caso non si fosse capito, è gnocca (Repubblica XL)
Jim Kerr: che voleva dire, esattamente, "nuovo sogno dorato"? (Io Donna)
Coldcut: "È imprevedible quello che succede quando il suono incontra la vita" (Hot)
45giri: il formato che doveva morire (Hot)
Hard-Fi: quelli che Scarlett Johansson non ha mai sentito nominare (Repubblica XL)
Incontrare Ursula Rucker e chiederle: "ma tu scrivi prima la musica o i testi?" (Hot)
Arctic Monkeys: come internet trasformò un cartone animato in realtà (Repubblica XL)
Tiga: "la prima volta che ti chiedono un remix è come la prima volta che baci una ragazza" (Hot)
Da Brian Eno ai Franz Ferdinand: di che cosa parliamo quando parliamo di "art-rock"? (Hot)
The Strokes: "il CBGB's? che si fotta" (Repubblica XL)
Confessions On a Dancefloor: Madonna e l'ultimo capodanno dell'umanità (Hot)
Mister Cartoon: il tatuatore più famoso del mondo e il suo ferro da stiro (Hot)
Art Brut: "abbiamo formato una band" (Hot)
Ozzy Osbourne: un vecchio zio nella casa degli orrori (Repubblica XL)
Tracey, Damien e Grayson: sai tenere un Segreto? (Io Donna)
Scuola Furano: fuga dalla scuola media (Hot)
Roisin Murphy: quella sua maglietta stretta (Rolling Stone)
Violante Placido, per gli amici Viola (Io Donna)
Joy Division, the movie: non esattamente Last Days, e nemmeno The Doors (Hot)
30 domande a... WhoMadeWho (Hot)
Allun, Offlaga, Uochi Toki e gli altri: marziani italiani (Repubblica XL)
Devendra, Sufjan, Rufus: le radici in un passato immaginario (Hot)
Sigur Ros: niente più strategia dell'oscurità , o quasi (Repubblica XL)
Arcade Fire: sette musicisti, tre funerali e un matrimonio (Repubblica XL)
C30-C60-C90: il culto del mixtape (Hot)
"Piripiri-piripiri-piripiri-pi": più famosa di Yesterday dei Beatles (Io Donna)
Tosca + The Dining Rooms: due dischi, quattro musicisti e sette bambini (Hot)
E arrivò il giorno in cui i lettori del Corriere conobbero le Coco Rosie... (Io Donna)
Tattoo You: sì, nel 2005 c'è ancora qualcuno che scrive articoli sui tatuaggi (Hot)
Springsteeniani d'Italia: il culto di Bruce (Io Donna)
From Genesis to revelation: la dj-culture scopre il prog? (Hot)
It began in Ibiza: la Summer of Love e tutto il resto (Hot)
A Grottaferrata, a sentire il nuovo album dei Subsonica, mentre loro mi guardano strano (Rolling Stone)
Joss Stone: mind the Gap, please (Io Donna)
Red Bull Music Academy: la scuola per dj più pazza del mondo (Rolling Stone)
Sk8r boi 2005: la musica che gira intorno allo skate (Hot)
Antony & The Johnsons: "volevo essere Isabella Rossellini" (Rolling Stone)
Coldplay/Guns'N'Roses: scusate il ritardo (Io Donna)
World Wide Clubbing: prima viaggiare, poi ballare (Hot)
Moby: "voglio vivere come dentro una tomba"
(Io Donna)
Discoinferno: i dieci anni che cambiarono il clubbing a NY (Rolling Stone)
Belle de Jour: "anal sex is the new black" (Io Donna)
Optimo: i biscotti per cani e il futuro del djing (Hot)
Polyphonic Spree: il meraviglioso mondo di Tim DeLaughter
(Musica di Repubblica)
Mercury Rev: in segreta migrazione (Rumore)
EMA: (mica tanto) European Music Awards (Io Donna)
White Stripes: i Kraftwerk del 2000? (Rolling Stone)
Kasabian: il Gabibbo e Charles Manson
(Musica di Repubblica)
The Cure: la vita è un lungo fascinoso imbrunire
(Rolling Stone)
Miss Violetta Beauregarde: ultra-Violetta! (Rumore)
Franz Ferdinand: il successo è una cosa che succede
(Musica di Repubblica)
Lollapalooza: Woodstock per la Generazione X
(Rolling Stone)
Io tigro, tu tigri, loro Le Tigre... (Rumore)
Duran Duran: Wild Boys vent'anni dopo
(Musica di Repubblica)
Radio Dept.: Radio Free Sweden (Rumore)
Milano-Roma-Barcellona: trans Soulwax express (Rumore)
The Libertines: "vuoi sapere che si prova ad avere nella band un potenziale Sid Vicious?"
(Musica di Repubblica)
Gabrielle Drake: Pink (Moon)base
(Rolling Stone)
Janet Jackson: e Dio creò le tette (GQ)
Discocaine: viaggio al termine del nightclubbing (Hot)
Beastie Boys: To The 5 Boroughs (Rumore)
2004: dance is (not) dead? (Rumore)
The Streets: "pensavo di essere noiosissimo, pensavo che nessuno mi capisse"
(Tutto/Rumore)
Golia & Melchiorre: un Bugo, anzi due (Rumore)
Malcolm McLaren: comprereste un'auto usata da quest'uomo? (Hot)
Do you remember the Summer of Love? (Rolling Stone)
PJ Harvey: e alla fine arriva Polly (Jean) (Rumore)
William Gibson: non tutte le predizioni devono per forza avverarsi (Tutto)
The Darkness: old Skool of Rock (Rumore)
Morrissey: un alieno a L.A. (Rolling Stone)
Von Bondies: Detroit, botte & rock'n'roll (Rumore)
Courtney Love: la fidanzata d'America (Rumore)
Coldplay: livin' la vida glamour (Rumore)
Iggy, ti presento Peaches... (Rumore)
Black Rebel Motorcycle Club: belli, neri e ribelli (Rumore)
The Rapture: punk, funk, moda & modelle (Rumore)
The Queer is Dead: trent'anni di rock non-solo-eterosessuale (Rumore)
I Maniaci Dei Dischi: il futuro è un dj a sei mani (Rumore)
La strada di Zwan: Billy Corgan e il tempo ritrovato (Rumore)
"Così Tanto Amore da Dare": in giro per Londra a caccia di Dj Falcon (Rumore)
Massive Attack: 3D, cuore di tenebra (Rumore)
Sigur Ros: "il mondo è più divertente di quel che potresti credere" (Rumore)
The Osbournes: gruppo di famiglia in un inferno (Rumore)
Last Night a DJ Saved My Life: essere dj nel 2002 (Rumore)
Primal Scream: "il problema è che noi non siamo gli Oasis" (Rumore)
David Holmes: una vita per il cinema (Rumore)
My Bloody Valentine: soffice come la neve (ma caldo dentro) (Rumore)
Stuart David: fold your book, child... (Rumore)
Chemical Brothers: è iniziato in Africa-ka-ka-ka... (Rumore)
Money Mark: lo spirito delle persone si infonde nelle macchine (Rumore)
Non solo Anniottanta: il lato oscuro dell'Eighties-revival (Rumore)
Solex: ovvero Beck con le mestruazioni (Rumore)
Starsailor: "purezza" è la parola chiave (Rumore)
Lamb: l'opposto dell'amore non è l'odio, ma la paura (Rumore)
Verdena: paura & disgusto dalle parti di Bergamo (Rumore)
Quando incontri Bjork e poi parenti e amici ti chiedono: "ma com'è lei veramente?" (Rumore)
Copia Icona: Thora Birch e il congelamento di Kate Moss (Rumore)
The rhythm, the traxx, the Basement, the Jaxx... (Rumore)
Radiohead: "odiare la musica è pericoloso" (Rumore)
Damon & Jamie: Gorillaz nella nebbiaz (Rumore)
Tool: i Radiohead del post-metal (Rumore)
Depeche Mode: l'heavy metal dello spazio interiore (Rumore)
Soft Cell: quest'ultima notte a Sodoma (Rumore)
Die Moulinettes: brevi amori a Jesolo e Bibione (Rumore)
Future Pilot AKA: Wild Thing dei Troggs è l'equivalente pop dell'uomo delle caverne (Rumore)
Daft Punk: 0ne m0re t1me? (Rumore)
Kings Of Convenience: un mondo di canzoni ideali (Rumore)
Riot Grrrls 2001: girls just want to have fun? (Rumore)
La Crus & Avion Travel: i nuovi tradizionalisti (Rumore)
Me and Alan McGee: le etichette che hanno fatto la storia, da Rough Trade alla Creation (Rumore)
Giuliano Palma & The Bluebeaters: it's a wonderful, wonderful life (Rumore)
Il giorno che Roni Size mi mandò (quasi) a quel paese (Rumore)
Mtv (de)Generation: vogliono trasformarci in Arancia Meccanica, ma noi siamo più veloci (Rumore)
Belle & Sebastian: "talvolta al mattino mi sveglio e mi sento Andy Warhol" (Rumore)
Yoshinori Sunahara: il non-luogo dell'anima (Rumore)
Londra: 333 italiani("D" di Repubblica)
Mr.Oizo: l'uomo che muove il pupazzo (Rumore)
Nine Inch Nails (e Marylin Manson): speranza e vaselina (Rumore)
Stupiti & Confusi: apologia (o quasi) di Chloe Sevigny (Rumore)
Mò Wax: non necessariamente trip-hop(Dance Music Magazine)
Pop Life!: dai Beatles ai Boo Radleys passando per i Sex Pistols (Rockstar)
"Generazione M": i ragazzi con la spina nel fianco (Rumore)
Saturday, May 06, 2006
«Per me non hai mai scritto una cosa così. Mai»
a
a
Chiunque si riempie la bocca di Lester Bangs, sempre. Chiunque è capace di dirti che, sì, chi scrive di musica oggi (in un “oggi” che dura più o meno dal 1982) non ha neanche un quinto dell’inventiva, della spregiudicatezza, dell’indipendenza di pensiero e dei coglioni di Lester Bangs. Sentendomi direttamente chiamato in causa, perché a parte estemporanei lavori tipo “responsabile del monitoraggio media giovanili per la chiesa di Scientology” come negli ultimi mesi*, è più o meno dal 1987 che mi guadagno da vivere principalmente scrivendo di musica, ci ho lungamente pensato. Ci ho pensato soprattutto nell’ultima settimana, leggendo - sul tram - la da poco tradotta nuova raccolta di scritti di Lester Bangs. E sono arrivato alla conclusione che, sì, è vero, nessuno di noi ha nemmeno un atomo della spregiudicatezza, dell’indipendenza etc etc etc di Lester Bangs, e per una semplice ragione. Lester Bangs era un cretino, a noi venuti dopo non è concesso di essere cretini. Non mi ci metto nemmeno nel ginepraio dei mille distinguo: «la quantità di dischi che escono oggi, la soglia di attenzione dimezzata, l’i-Modalità di ragionare mentalmente per playlist anzichè per opere complete come gli album, e bla bla bla». No, no. Ne faccio solo una pura e semplice questione di cretineria. Lester Bangs era, oltre a tutte le cose belle che non sto a ripetervi perché in italiano non esiste un termine adeguatamente equivalente all’inglese waxing poetic, un cretino. Uno che ha preso delle cantonate pazzesche. Uno che ha, talvolta, e forse deliberatamente, totalmente mancato il punto.
Qui da noi invece non si può essere cretini perché qui da noi scrivere di musica è una roba seria. Qui da noi se uno osa andare poco poco fuori del seminato è subito tutto un sussiegoso levarsi di ditini, di «eh, no», di infastidite richieste di mantenersi attinenti alla materia. La cretineria non è contemplata, mancando completamente qualunque capacità d’improvvisazione intellettuale (e secondo me pure emotiva) da parte del 94% di chi si occupa professionalmente o semiprofessionalmente di musica scritta.
Devo dire che ho la coscienza a posto. Nel corso della mia vita ho scritto una ragguardevole quantità di cazzate. Me lo conferma il fatto di continuare a incontrare, periodicamente, persone che me le rinfacciano. Fino a qualche anno fa era la recensione - entusiastica - del primo e credo unico disco di Monk & Canatella a riscuotere i maggiori dissensi («ah, ma tu sei quello della recensione di Monk & Canatella»: mi ha sempre deliziato che la micro-fama della recensione tra i lettori italiani di riviste specializzate avesse ampiamente superato per longevità quella del disco cui si riferiva, e soprattuto quella dei suoi due autori). Ce ne furono un paio d’altre, tra cui mi pare il primo disco solista di Richard Ashcroft. Da un anno a questa parte però quasi tutti i ditini alzati, le teste piegate di lato e le boccucce imbronciate sono per la recensione di Human After All dei Daft Punk uscita su Rolling Stone. Il fatto di aver dato il massimo voto in stellette ad un disco ed averlo definito oggettivamente sublime dopo aver passato 2.500 battute a spiegare le ragioni per cui era a tutti gli effetti un disco disonesto e mal fatto, è una cosa che ha mandato in cortocircuito più di una testa. Ma le migliori recensioni non nascono quasi mai dai migliori dischi. Anzi, le recensioni non nascono quasi mai dai dischi. Almeno, a me succede così. È il livello di cretineria che mi sono riservato nell’ambito dello svolgimento di questo lavoro, e lo trovo un livello di cretineria salutare sia per me che scrivo sia per chi legge. Ad esempio: la recensione di Dig Your Own Hole dei Chemical Brothers uscita su Rumore nel 1997. Lo dicevo non mi ricordo più a che proposito qualche post più sotto: la recensione di Dig Your Own Hole in realtà parlava di una tipa, tedesca, con cui avevo appena avuto una specie di brevissima storia.
Era, appunto, il 1997, e all’epoca abitavo a Roma. Ero ricco e famoso, e ogni sera conducevo un popolarissimo show “alternativo” sul secondo canale della radio di Stato. Lei era tedesca e aveva passato un anno e mezzo in Italia per un dottorato post-laurea che aveva a che fare con la geologia, il restauro, la chimica industriale o forse tutte e tre le cose. Non stava a Roma, e il weekend prima di ripartire per la Germania decise di accettare l’invito e venirmi a trovare, con la conseguenza che arrivò alla stazione di Roma Ostiense alle 12 e 29 di un sabato di marzo con tre enormi valigie contenenti, in pratica, tutto quello che possedeva. L’immagine era di una persona pronta a trasferirsi nella mia vita definitivamente, ma in realtà fino a quel momento ci eravamo visti tre volte e baciati una (in due tempi: all’uscita da una gelateria e nel portone sotto casa dove abitava). Due sole cose sono rilevanti ai fini di questa storia: la prima è che dieci minuti dopo esserci conosciuti, alla mia frase «i Nirvana, non so se hai presente» lei rispose: «certo, lo stato ultimo dell’individuo nella religione buddista», cosa che fece istantanteamente scattare in me un’ondata di desiderio paragonabile a ciò che per certi maschi è l’idea di “scoparsi una vergine”. La seconda è che il suo arrivo a Roma mi fece fischiettare per tutta la settimana precedente quel motivetto degli Einsturzende Neubauten che si intitola Sie, quello che si conclude con la frase «abgang sie», cioè “entra lei”, e io adoro quando le canzoni riescono a scavarsi una terza dimensione dentro la vita quotidiana.
La giornata fu divertente. Lasciammo le sue tre valigie a casa e io le chiesi di tradurmi il testo di una canzonetta tedesca con cui stavo in fissa in quel momento, di un gruppo chiamato Die Sterne. Venne fuori che il testo diceva una cosa tipo «divertiamoci e accoppiamoci promiscuamente finchè siamo vivi, perché domani chissà» (è evidente che in quel momento era Nora Ephron a sceneggiare la mia vita: quello che ancora non sapevo era che Nora stava per subappaltare il lavoro ai fratelli Farrelly). Girammo per Roma, e la sera la portai a cena fuori, un ristorante siciliano a San Lorenzo. Un ristorante di quelli con il menu scritto su un’unica lavagna all’ingresso, i pomodori secchi appesi e lo chef che si crede fico perché mischia piatti di diverse latitudini del bacino del mediterraneo (so 1997, I know). Ad un certo punto lei si mise a raccontare di un tale, uno che doveva-decidere-se-era-ancora-il-suo-ragazzo, che abitava in una citta tedesca X, e di un altro che vedeva, un produttore televisivo, che invece stava in una città tedesca Y.
«Due amanti in due diverse città?».
«Ti scandalizza che siano due?» rispose lei.
«Figurati. Qual è esattamente il numero a cui pensi di fermarti?» dissi scandendo bene-bene le parole per evitare equivoci dovuti alla barriera linguistica. Lo zoccolissimo sorriso di lei - che qualunque tribunale o tribunetta televisiva avrebbe omologato alla risposta «beh, non meno di tre entro la fine della serata» - trasformò nel volgere di un istante la mia, di serata, da facciata B di un disco minore di Joni Mitchell in una roba tipo cartone animato di Tex Avery (quello col lupo che va al night, per intenderci), solo che anziché fischiare con due dita in bocca per richiamare l’attenzione del cameriere, farmi portare il conto, trascinare la crucca fuori dal ristorante e - lanciata sgasando la Panda sulle strade della Capitale - riportarla al bachelor pad ove per tutta la notte le avrei con bell’agio illustrato la superiorità del maschio nato a Sud del Brennero, anziché fare questo - che è esattamente ciò che avrebbe fatto un Uomo, cosa che io non ero, ad esempio perché per me bachelor pad era essenzialmente un pezzo del titolo di un mini-lp degli Stereolab, uno nel quale c’era una canzone profeticamente intitolata We’re Not Adult Oriented - anziché fare questo, dicevo, feci un’altra cosa. A mia giustificazione dirò solo che ero giovane. Anzi, non ero giovane, ma non esistevano ancora ancora l’ADSL e la tariffa flat, e dunque non avevo ancora avuto modo di passare notti insonni sui forum creati dai lettori di Neil Strauss, Tucker Max e (il mio preferito) uno che si fa chiamare “Gunwitch”. Non ero ancora il tipo di uomo che riesce a concepire - come invece oggi, maggio 2006 - un pensiero tipo: «vorrei fossi capace di riempirti la bocca di me allo stesso modo in cui te la riempi di Lester Bangs quando parli di critica rock».
Così, invece, feci quello che sa vivere, feci quello che non ha fretta. Proseguii la conversazione al tavolo del ristorante siculo con l’allegra leggerezza di chi pensa di avere già in tasca il biglietto vincente della lotteria. La portai a girare per piazza Navona by night cogli stornellatori, i punkabbestia coi cani e quelli che fanno i ritratti, e poi a bere il Porto in un posto che non mi ricordo se fosse il Bar della Pace o il Bar del Fico, me li confondo sempre, ma in entrambi i casi stiamo comunque parlando di posti con le panche a imitazione botti in rovere su cui siedono la crème delle attricette del cinemaitaliano, mica cazzi. Lei non disse ad ogni volgersi in giro dello sguardo «mol’to pitt’oresco» come Enrico Montesano nella celebre gag della turista inglese, ma secondo me lo pensò. E invece io, ormai lanciatissimo nel mio ruolo di Christian De Sica dell’indie-rock, guidando verso casa feci tappa allo strategico banchetto dei fiori di viale Mazzini angolo piazzale Clodio, aperto tutta la notte, per donarle una rosa rossa (quando l’Aulin che ho appena preso farà effetto e rileggerò questa frase sento che vomiterò) e poi, visto che era di strada, fermai pure a quella terrazza su via Trionfale da cui si vede il quartiere Prati dall’alto, e lì finalmente ci baciammo, due baci non particolarmente lunghi né particolarmente - come dire - convinti. Ma è solo l’inizio, mi dissi io. Ed in effetti fu solo l’inzio, dal momento che arrivati a casa - ma non appena arrivati a casa, proprio nel momento stesso in cui varcavamo la porta di casa - lei si chiuse con un tonfo nel bagno e vomitò il cous cous di pesce, e il tiramisù della casa, e il Malvasia delle Lipari, e forse anche pezzetti di anima. Il tutto per la durata (record) di circa quarantacinque minuti.
Com’è facile intuire non scopammo quella notte (però nemmeno rimanemmo svegli fino alle cinque chiacchierando, che sarebbe stato un meritato contrappasso per uno che in quei giorni stava ricomprandosi in cd su internet l’intero catalogo della Sarah Records già posseduto in vinile). Tutto ciò generò un pesante imbarazzo che sovrastò come una nuvola grigia l’intero giorno dopo, cioè domenica. In quanto domenica, in quanto Roma, in quanto lei turista crucca e io (come si è visto) persona con la spericolata fantasia di un geometra del catasto, la mattina la passammo girando per il mercato di Porta Portese. Parcheggiai la macchina di fronte al cinema Sacher, il che mi consentì di recitarle la mia celebre piéce dal titolo: “la prima volta che andai al cinema a Roma, al Capranichetta, seduto nella fila davanti alla mia allo spettacolo delle 22.30 c’era Nanni Moretti, da solo. Il film era un film di Eric Rohmer”. Non ricordo cosa facemmo il pomeriggio (c’era sempre quella nuvola grigia che incombeva). Vista la spericolata fantasia mostrata nelle ventiquattr’ore precedenti immagino di averla portata in quel posto dove c’è una porta chiusa dal cui buco della serratura si vede Roma dall’alto. Oppure al cimitero inglese a Piramide, in cui c’è la tomba di uno che si chiama William Gibson che con persone sufficientemente di buone letture è sempre un discreto coup de theatre.
La domenica sera, poi, alla fine scopammo. E fu quella che in termine tecnico si definisce una triste scopata. Il tipo di scopata che bisognerebbe avere il buon gusto e la maturità di non iniziare nemmeno, quando ciò che tutte le premesse annunciano è con ogni evidenza destinato a risolversi in qualcosa di rapido, malinconico, educato e fondamentalmente poco divertente per tutti e due. Una scopata arrivata troppo tardi, troppo per obbligo di “buon vicinato” (lei), troppo per obbligo di mostrare (io) che anche se i muri di quella casa debordavano di qualunque 12” o 7” o cd o picture disc mai inciso dagli Smiths, il suo abitante invece mica rientrava nello stereotipo del fan degli Smiths, no (che poi: secondo voi lei aveva la minima idea di chi fossero The Smiths o di cosa parlasse How Soon Is Now? Io non gliel’ho mai chiesto. «Certo, Adam Smith, il famoso economista», brrr...). Nonostante tutto questo l’addio la mattina dopo sul marciapiede del binario alla stazione di Roma Termini fu struggente, ancora non capisco perché. Lei aveva un groppo alla gola, e pure io non ero esattamente cool come Pierce Brosnan. Quello che mi restava ancora da fare, una volta che l’ultimo sbuffo di fumo del treno scomparve dietro l’orizzonte in direzione Nord (nel frattempo i Farrelly avevano passato il lavoro alla coppia Ercolani & Rondolino), era scrivere la recensione di Dig Your Own Hole, ed è esattamente quello che feci appena tornato a casa.
Questa è la recensione come fu pubblicata su Rumore nell’aprile 1997:
Siamo di fronte ad una cosa enorme. Un disco attesissimo perchè è stato dal loro precedente Exit Planet Dust del 1995 che certe cose hanno bene o male, sotterraneamente, cominciato a muoversi. Un disco dal quale tutti si aspettavano precise indicazioni per il futuro (perchè tutti ormai hanno capito, anche se nessuno l'ha ancora sentito, che il disco dei Prodigy sarà una bufala di proporzioni enciclopediche). Un disco dopo il quale il mondo non sarà più lo stesso perchè è un po' come quando ti innamori, e qualcosa nel tuo modo di percepire certe cose cambia comunque per sempre (in bene o in male).
Peccato solo che la sorte o le strategie di marketing l'abbiano fatto uscire qualche mese dopo Homework dei genietti cuginetti Daft Punk, rubandoci così la sorpresa di ricevere da loro, dai Chemical, la Rivelazione che il futuro - o almeno il presente - si chiama funk. Funk a palla, con basso sbleng-sbleng come quello che apre il disco e “Block rockin' beats” (che inizia con lo stesso drone cupo che apriva Exit Planet Dust), ed anima le successive “Dig your own hole” ed “Elektro bank”. Funk che Prince, poverino, se lo può giusto sognare la notte a Minneapolis, come quello di “Lost in the K hole”.
Funk che di botto diventa acid-house e poi ancora meno, singulto elettrodomestico senza quasi storia, il pulsare celibe di qualche Roland di seconda mano, quindi l'imprevedibile tributo a Martin Rev ed Alan Vega (santi protettori di circa quattrocentomila “dui” elettrotrashosi dalla preistoria ad oggi) di “Piku”. Per finire con “Where do I begin?”, electro-folk cantato dalla voce di Beth Orton e addizionato di strati e strati di loops fracassoni, e in coda a tutto “The private psychedelic reel”, consuntivo di tutto quanto è fin qui successo, nove minuti e ventidue sui quali si potrebbe scrivere un libro. Un pazzesco crescendo wagneriano; fine del mondo, cavalcata delle valchirie, Album Bianco e tutto il checcazzo che sono riusciti a metterci dentro: sitar, sax alla Andy Mackay (Roxy Music), memorie dal rave, sirene spiegate, teenagers globali, la vita dopo la morte e tutto il resto. L'abilità nel mescolare lascia stupefatti, senza parole. E silenziosamente, infatti, salutiamo l'avvento di una nuova era: quella della post-techno.
E questa invece è la vera recensione, che finora nessuno ha mai letto:
Siamo di fronte ad una cosa enorme? No, direi proprio di no. Ad essere enormi erano solo le aspettative che, senza nemmeno rendermene conto, avevo su di te e su di noi. Il problema è che erano due anni buoni - dal 1995, dall’estate in cui ascoltavo il primo album dei Chemical Brothers Exit Planet Dust - che non incrociavo sulla mia strada qualcuno che mi interessasse più di buongiorno e buonasera. Perché, vedi, per me con le donne è esattamente come per i dischi. La maggior parte non mi interessano. La stragrande maggioranza non mi interessano. Poi ogni tanto ce n’è uno in cui trovo qualcosa: uno spunto d’infinito, una suggestione di eternità.
È vero, come hai detto tu la mia casa sembra costruita nei dischi, scavata nel vinile e nella plastica delle jewel-box, ma io so che in realtà potrei fare a meno di quasi tutti. Il punto è che con i dischi io ci lavoro, ma dovendo scegliere so che mi basterebbe uno scaffale di quelli alti e stretti dell’Ikea. Mi basterebbero cinquanta cd, ma forse anche meno, trenta. Forse uno sarebbe Dig Your Own Hole. Lo sarebbe? Davvero? Difficile dirlo, perché il problema adesso - lo so - è che questo disco (che sto ascoltando su una cassetta al cromo, questo disco che non è nemmeno ancora uscito, che tranne i Chemical Brothers ed io ancora nessuno al mondo ha ascoltato, anche se quando te l’ho detto la cosa non sembrava impressionarti particolarmente), questo disco, dicevo, rimarrà per sempre, dentro la mia testa, collegato a te.
Nei trenta dischi sicuramente uno dei Chemical Brothers ci dovrà essere, ma Exit Planet Dust o Dig Your Own Hole? Il problema è che Dig Your Own Hole mi sta piacendo più dell’altro, ma Leave Home è inarrivabile e Block Rocking Beats non le regge nemmeno un moccolo di candela. No, il problema è che ormai TU sei Dig Your Own Hole, e Exit Planet Dust - che fra l’altro, in uno strano twist di giustizia divina, è la persona che ci ha fatto conoscere - è totalmente, completamente, inderogabilmente fuori dalla mia vita. Fra l’altro la mia vita Exit Planet Dust l’ha abitata sufficientemente a lungo per non essere solo Exit Planet Dust ma un sacco di altri album. Jar Of Flies degli Alice In Chains ad esempio, So Tough dei Saint Etienne. Quel cofanetto quadruplo sulla storia del reggae. Persino In Utero, volendo. Ero stato a Bologna con lei il giorno in cui la sera i tg diedero la notizia della morte di Kurt Cobain. Una giornata di merda, come il 100% delle giornate che ricordo insieme a Exit Planet Dust.
Il problema, capisci, è che scegliere Exit Planet Dust è un tributo al passato che non mi va davvero di fare (certo, Leave Home...), però scegliere Dig Your Own Hole significa anche scegliere la transitorietà degli eventi, la consapevolezza (forse matura, chissà), che le cose che più ci piacciono non ci appartengono, che un singolo paraculo ma non geniale come Block Rocking Beats non vuol dire nulla, è solo un opener, e un album non si giudica dal suo primo singolo. Un giorno forse qualcuno inventerà un oggetto che ci libererà dal pensare in termini di album, e allora saremo tutti più felici. Felici di portarci dietro soltanto le canzoni che ci piacciono davvero (o ci sembra ci piacciano davvero) e liberi di prendere della natura delle persone soltanto quei pezzi che ci servono veramente. L’unicum scoparirà, la visione olistica e monogama sarà un buffo retaggio della cultura dei nostri avi. L’unica certezza, stasera, mentre tu sarai appena tornata alla tua vita in Germania, è che The Private Psichedelic Reel, e tu insieme a lei, rimarrete una grande, gigantesca, totale, lussuriosa esplosione di vita - oltre che un grande buco nero, una spaventosa idrovora di sogni, certo, perché le due cose vanno sempre insieme. Anche quando, perchè un giorno succederà, di te mi sarò scordato il nome.
(PS: non ho mai comprato un i-Pod. Né credo lo comprerò mai)
|